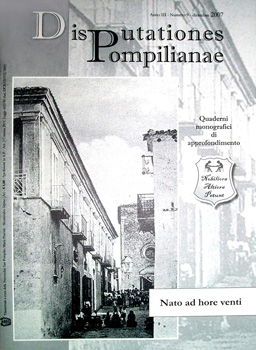 Medaglie e monete tra i reperti archeologici della Costa della Mènola
Medaglie e monete tra i reperti archeologici della Costa della Mènola
Ero ragazzo, quando cominciai a raccogliere alcuni reperti antichi tra le zolle, nella terra dei miei nonni paterni alla Costa della Mènola, attorno al casino di Minòcchju, acquistato dal nonno Angelomaria con i dollari risparmiati, grazie alla sua emigrazione negli USA, all’inizio del Novecento, che noi ereditammo e fu abbattuto dopo il terremoto del 1980. Raccoglievo, tra lo scetticismo e l’incredulità dei parenti prima, e degli estranei poi, ciò che era inutile nella cultura materiale dei contadini. Per loro aveva importanza solo ciò che era di utilità pratica o si poteva cedere a terzi in cambio di denaro. Un comportamento, il loro, giustificato dal fatto che si viveva in un’economia di sussistenza. Raccoglievo monete antiche, medaglie, frammenti di oggetti in ceramica (sòldi antichi, mmiràgli, àshculi di vacìli). Li ripulivo e li conservavo con cura. Non avevano valore commerciale, ma io ne ero affascinato e incuriosito. Iniziava così per me, inconsapevolmente, il viaggio fantastico tra la storia, l’arte, la poesia, l’affabulazione, l’etnografia, l’archeologia, la memoria e la cultura in generale. Ancora oggi esso prosegue
e mi fa sentire idealmente il ragazzo che fui in quella ripida campagna, sperduta e lontana dal mondo. Una volta essa era fiorente e animata dai contadini e dai ciucai chiassosi, che arrancavano a fatica con asini carichi per i ripidi sentieri. Ricordo tanta gente che scendeva dal paese e passava davanti al nostro casino, per andare a lavorare nei propri campi, a ridosso dei valloni del Fosso Palumbo e della Ripa della Conca. Quando si ritirava chiedeva talvolta una bevuta d’acqua fresca. Non esisteva il frigorifero e l’acqua la tenevamo nel barile, all’imbocco della cantina al pianterreno del casino. Non c’era l’acqua corrente e l’approvvigionamento lo si faceva ai fontanini del paese, dove l’acqua arrivava ogni tre giorni, o alla fontana della Monaca, di proprietà della famiglia Pizzillo. Erano tempi grami, eppure, nei miei ricordi di emigrato, quella campagna, coltivata da tutti con cura e amore, con tanti alberi da frutta di tutte le stagioni e filari di viti, sotto i quali venivano seminati cereali e leguminose, mi è rimasta impressa come un eden. Oggi, purtroppo, essa è abbandonata e inselvatichita. I pochi alberi domestici rimasti, come mandorli, ulivi, viti, ciliegi, peri, meli e fichi sono soffocati da olmi, gaggie, ailanti, rovi, vitalbe, piante del sottobosco e sterpaglie e, tra non molto, questa terra non sarà più in grado di restituire altri reperti del passato.

Veduta di Montecalvo Irpino dopo il 1900, in una rielaborazione di Angelo Siciliano.
Dopo il terremoto del 1962 è stato abbandonato anche il soprastante centro storico del paese, per secoli cuore pulsante della comunità. E a nulla è servito che le case e alcuni palazzi siano stati ristrutturati o ricostruiti nel corso degli anni. La gente è emigrata o si è trasferita nei nuovi anonimi quartieri del paese e non vi fa più ritorno. Sicuramente ha pesato molto il ritardo con cui i lavori di recupero sono stati approvati e realizzati.

Veduta di Montecalvo Irpino attualmente.
Ricordo con qualche rimpianto i contadini che mettevano insieme rottami di ferro, oggetti di rame e monete rinvenute nella terra, e vendevano il tutto per poche lire al robivecchi, un arianese trapiantato a Montecalvo, Carminùcciu Fierruviécchju, che aveva messo su famiglia con una nostra compaesana e, all’inizio della seconda metà del Novecento, girava periodicamente per le periferie del paese spingendo il suo carrettino, su cui esponeva anche dei giocattoli.
I segni e i colori dei frammenti ceramici avrebbero stimolato la mia fantasia nella realizzazione di un centinaio di disegni e opere pittoriche, con cui si sarebbe potuto decorare tante vacìli, piatti grandi. Addirittura, accarezzavo l’idea di avviare una piccola fabbrica di ceramica decorata. In seguito, studiando quei trenta chili di cocci, messi insieme negli anni, avrei scoperto che facevano parte di stoviglie e maioliche prodotte in massima parte dalle fabbriche arianesi, a partire dal XII secolo, quando fu il re normanno Ruggero II (1095-1154) a portare ad Ariano Irpino dei ceramisti saraceni, che si insediarono in loco creando delle fabbriche di maioliche. E a questo proposito può risultare istruttiva e interessante una visita al bel Museo Civico della ceramica di Ariano Irpino.
|
Mamma Bella e S. Pompilio, in un dipinto di Angelo Siciliano del 2004. |
Col tempo avrei cominciato a raccogliere frammenti in terracotta di varie epoche e i token, dischi fittili e litici, e reperti di pietra come asce, grattatoi, punteruoli, bulini, bifacciali, scalpelli a mano, pestelli e percussori, tutto rigorosamente in pietra e qualcuno in basalto, e qualche scoria di fusione dell’età del Bronzo. Alcuni di questi reperti in pietra potrebbero appartenere al Paleolitico, oltre 10.000 anni a. C., e la loro rilevante quantità, finora rinvenuta, fa supporre che in questo luogo vi fosse un’officina litica preistorica. Alcune monete antiche rimandano ai Romani, ai secoli del secondo millennio e, quelle con le effigi dei re Borboni, al Settecento e all’Ottocento. Le medaglie di bronzo, di rame, o d’ottone, e il piccolo crocifisso appartengono a secoli diversi. La Madonna è la più effigiata. Ben 15 volte ricorre su di esse la sua immagine: Madonna con Bambino, Madonna del Rosario, Madonna delle sette spade o sette dolori, Madonna di Loreto, Madonna di Montenero, Maria Immacolata, S. Maria dell’Arco e Vergine irraggiata. Le altre effigi riguardano l’Arcangelo Michele, B. Gerardo Maiella, Cristo Salvator Mundi, S. Anna Aemy, S. Antonio da Padova, S. Caro, S. Domenico a Cocullo, S. Elisa, S. Francesco, S. Filippo, S. Germana, S. Ludovico, S. Maria Goretti, S. Pietro, S. Pompilio Maria Pirrotti, S. Rosa di Viterbo, SS. Sacramento e diversi altri santi indicati con le sole iniziali, o senza alcuna lettera alfabetica. |
Singolare è la medaglia di S. Domenico, che si festeggia a Cocullo (Aq), in Abruzzo, il primo giovedì di maggio, con la processione dei serpari, che richiama tanta gente da fuori regione. Rettili di vari tipi, fatta eccezione di quelli velenosi, vengono catturati dai serpari nelle campagne circostanti nelle settimane precedenti ed esibiti, appesi attorno al collo durante la processione.
Anche la statua del santo, lungo il tragitto della processione, è avvolta da lunghi serpenti che se ne stanno attorcigliati e tranquilli. Una volta celebrata la festa, anche per via degli accordi stipulati con le associazioni ambientaliste, i rettili sono liberati nel territorio di cattura e non più venduti, come succedeva una volta, al pubblico accorso da fuori per l’occasione.
Il rito dei serpari di Cocullo risale al XII secolo e si ammanta di antiche tradizioni pagane, quando i serpari erano dei sacerdoti, impropriamente collegati alla dea Angizia, divinità marsa e latina, venerata a Luco dei Marsi. Anche la scelta del giovedì, giorno in cui nei secoli passati si celebravano le feste del Corpus Domini e dell’Ascensione, si deve al fatto che esso era il giorno dedicato a Giove, Zeus in Grecia, capo degli dei pagani sull’Olimpo. E a questo proposito va detto che vi è stata una tacita coesistenza nei secoli tra la religione cristiana e le credenze magico-rituali, che affondano le radici nel paganesimo. Talvolta, è successo che queste ultime siano state assimilate dal Cristianesimo.
In passato, a Montecalvo Irpino, i serpari, o meglio gli incantatori di serpenti, erano chiamati ciaràvuli, suonatori di corno, dal termine greco kerallos, che significa appunto corno. Generalmente, però, i nostri serpari attiravano i rettili con dei semplici fischi e, dopo averli catturati, se li mettevano a tracolla e si esibivano con una certa baldanza tra i compaesani spaventando le ragazze. Ma ciaràvulu stava pure per ciarlatano, millantatore, perdigiorno.
Queste medaglie, che la terra ha restituito nei decenni, non sono una collezione sistematica, perciò essa è chiaramente incompleta. Infatti, se si fa riferimento ai pellegrinaggi che facevano i nostri avi, mancano le medaglie di Mamma Schiavona di Montevergine, di S. Filomena di Mugnano del Cardinale, di S. Gennaro di Napoli, dell’Incoronata di Foggia, di S. Nicola di Bari. Tutti santi, nelle cui chiese o santuari i fedeli dell’Irpinia e non solo, sino a metà Novecento, si recavano in pellegrinaggio a piedi, in carrozza, in calesse o a cavallo, nelle stagioni intermedie, quando i lavori nei campi diminuivano e il tempo era né troppo freddo né troppo caldo. Tuttavia, a questo riguardo, vi sono una medaglia, un po’ malconcia, del nostro S. Pompilio, che presenta al rovescio il santuario di Campi Salentina, quella di S. Gerardo Maiella, quando era ancora beato, tre della Madonna di Pompei, quattro della Madonna di Loreto e quella con S. Michele Arcangelo, che per i cristiani ha come simboli la spada, la bandiera e la bilancia per la pesa delle anime. Egli conduce le anime dei defunti davanti al tribunale divino e per questo, in epoca paleocristiana, fu identificato con Mercurio, il dio romano del commercio e dei mestieri. Nella bibbia è il principe degli angeli, che combatte per Israele e fa precipitare dal cielo quegli angeli che, sotto la guida di Satana, si erano ribellati a Dio. È il messaggero divino che scacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, dopo il peccato originale. È il patrono della nostra Polizia di stato e fu anche patrono militare dei Longobardi, il cui luogo di riferimento è Monte Sant’Angelo sul Gargano, col suo santuario nella grotta eretto a ricordo della vittoria ottenuta sui Saraceni nel 663. A questo arcangelo è dedicato anche il monastero di Mont-Saint-Michel nel nord della Francia.
L’anno più antico, riportato sul rovescio della medaglia con S. Elisa, è il 1625. Ma non è detto che qualcuna non sia addirittura più antica.
Le otto monete, con le effigi dei re Borboni, sono del Settecento. Non si può fare a meno di pensare agli antenati per le cui mani questi dischetti di rame sono passati, chissà quante volte, per l’acquisto di qualche toscanello o un pugno di sale. Quattro monete furono coniate sotto re Carlo II (1716-1788), diventato poi re Carlo III di Spagna nel 1759, dopo la morte senza eredi di suo fratello re Ferdinando VI, e quattro sotto suo figlio re Ferdinando I di Borbone (1751-1825), già IV come re di Napoli e III come re di Sicilia. Inquadrano il Settecento, il secolo in cui visse il nostro santo, San Pompilio Maria Pirrotti (Montecalvo Irpino 1710 – Campi Salentina 1766), che si festeggia il 20 agosto. È uno dei santi irpini e nel 2000 papa Giovanni Paolo II ne ha canonizzato l’ultimo, Alberico Crescitelli (Altavilla Irpina 1863 – Cina 1900), missionario e martire in Cina, dove il suo corpo fu gettato in un fiume.
I “reperti” del sacro popolare della cultura orale: religiosità, fede, devozione e credenze magiche che hanno radici molto lontane
Anche l’archivio della cultura orale, che ho messo insieme in venti anni di meticolosa ricerca sul campo a Montecalvo, di cui una parte consistente attiene al sacro popolare, testimonia il rapporto degli antenati con la religione, la devozione e la fede, attraverso una trentina di cunti sui santi, in cui essi sono talvolta bonariamente presi in giro, una ventina di canti religiosi, qualche preghiera medievale, alcune filastrocche e ninne nanne, i detti, gli aneddoti e le maledizioni, in cui sono coinvolti alcuni santi. Ma con la religione convivono pure la magia, la blasfemia e il diabolico, come risulta dal poema contadino “Angelica”, di 107 quartine, che recuperai nel 1990. Infatti, con la fede e la devozione, hanno resistito nei secoli miti e leggende, reminiscenze o vere e proprie eredità pagane, neanche tanto celate, credenze magiche e comportamenti ritualizzati. Questo materiale, riguardante la civiltà agropastorale, svanita verso la fine del Novecento, si è addensato nei secoli e riassume in qualche modo l’immaginario collettivo dei nostri avi. Ora lo si può indagare, analizzare e interpretare per farsi un’idea della loro fede e delle loro credenze. Esso attesta che, con la superstizione e le credenze magico-rituali, molto radicate, i contadini erano portatori di una genuina spiritualità, che si manifestava sia nelle cerimonie religiose ufficiali che in occasioni non liturgiche. È scritto in dialetto irpino dell’Ottocento, con traduzione in lingua a fronte, e nel suo insieme rappresenta un patrimonio straordinario della nostra cultura orale, comune in buona parte al Meridione d’Italia.
Se si volesse capire a pieno il senso e il contenuto del materiale suddetto, parte del quale ha radici lontane, non basta rifarsi ai Romani, al loro rapporto con le divinità, e poi al Cristianesimo. Bisogna andare indietro nel tempo, quando la nostra penisola era abitata da genti pre-indoeuropee, con culture e lingue proprie, differenti culti e divinità, che nel tempo si sovrapponevano e stratificavano. Poi si arriva alle popolazioni italiche, tra cui i progenitori delle genti sannitiche.
I Sanniti erano suddivisi in quattro tribù: Carricini, Pentri, Caudini e Irpini. Ad essi, però, dovrebbero essere aggiunti i Frentani.
A partire dal V secolo a. C., si consolidarono come struttura economica, politica e sociale. Hanno lasciato qualche necropoli e ve n’è una a tumuli, estesa e importante, sopra Casalbore (AV), dov’è anche un tempio sannitico, denominato “Tempio italico”. Non crearono documenti scritti, per cui la loro storia può essere ricostruita, grazie agli scrittori antichi, alle scoperte archeologiche e ai sistemi di vita dei popoli sabelli della Campania e di altre aree geografiche.
|
Necropoli sannitica a Casalbore (AV). |
Area mefitica della Malvizza a Montecalvo Irpino. |
Fieri e bellicosi, furono temibili avversari dei Romani, per la conquista e il dominio sull’Italia peninsulare. Le ostilità con Roma, iniziate nel 343 a. C., si sarebbero chiuse solo nell’82 a. C. con lo sterminio di ottomila prigionieri sanniti, ordinato da Silla, dopo la battaglia di Porta Collina. Il Sannio, territorio dei Sanniti, diventava così colonia romana con Isernia e Benevento.
Gli Irpini divennero un’etnia autonoma nel 268 a. C., dopo la sconfitta riportata dalla Lega sannitica. Furono sottomessi dai Romani nel 209 a. C. e sconfitti definitivamente nella guerra sociale dell’83 a. C., dopo l’ennesima ribellione verso Roma.
La cerimonia sacra più importante dei Sanniti era il Ver Sacrum, la Primavera sacra. Per scongiurare i cattivi presagi e ingraziarsi la divinità, i bambini maschi nati in primavera erano dedicati al dio Mamerte (Ares per i Greci, Marte per i Romani). Non venivano immolati, ma allevati normalmente come gli altri bambini. Una volta raggiunta la maggiore età, i coscritti maschi, nati nella stessa primavera e dedicati a Mamerte, erano equipaggiati ed esortati a partire per andare a conquistarsi un proprio territorio seguendo un animale guida, che avrebbe indicato loro dove fondare il proprio villaggio.
Gli Irpini, come altri popoli antichi, durante una “Primavera sacra” dedicata al dio della guerra Mamerte, erano andati alla conquista di un nuovo territorio in cui stabilirsi, crescere e prosperare. Erano un popolo “totemico”, nel senso che avevano un’insegna votiva con un proprio simbolo, il lupo (hirpus) come animale eponimo, diverso da quello degli altri popoli. I Piceni, infatti, avevano adottato il picchio (picus), mentre i Sabini e i Sanniti avevano scelto il toro (bos).
I Sanniti, si diceva prima, erano andati alla conquista dei territori dell’Italia centro-meridionale. E proprio su quei territori si consolidò un’isoglossa, l’area osca, cui appartiene il dialetto irpino, ben definita geograficamente, che parte dall’Abruzzo e arriva sino alla Calabria inglobando il Molise, il Sannio, l’Irpinia e la Lucania.
Essi conducevano vita semplice. E semplici erano i loro riti religiosi, sotto la guida di sacerdoti, che erano pure sciamani e uomini di scienza, consapevoli del legame esistente tra sovrannaturale e mondo terreno. Ritenevano che molti luoghi fossero abitati dagli dei e due di essi si trovano in Irpinia: la zona mitica di Ampsanctus o Ansanctus (Valle d’Ansanto che va da Rocca San Felice fino a Carife) e la campagna di Aeclanum (Mirabella Eclano). Probabilmente tale era considerata anche l’area mefitica della Malvizza, in territorio montecalvese, non lontano da Aequum Tuticum (tuticum è un termine osco, da touto, popolo – Cfr. E.T.Salmon, Il Sannio e i Sanniti, Einaudi editore, Torino 1985), città preromana, ora in territorio di Ariano Irpino, e forse una delle capitali federali del Sannio antico. Da queste parti passa il tratturo Pescasseroli-Candela, che pare esistesse già nel Neolitico, 4000 anni a. C., e fa parte della rete viaria di Tratturi e Tratturelli dei Sanniti nell’Italia Centro-Meridionale.
Relativamente all’area mefitica montecalvese ho raccolto tre cunti. Uno riguarda Caronte, ritenuto responsabile della fuoriuscita dei gas venefici dalle viscere della terra. Gli altri due narrano di una taverna in cui si praticava l’antropofagia: in uno di essi è lo stesso Cristo che, passando di lì cogli apostoli, la fa sprofondare dando origine all’area che ha aspetto di solfatara; nell’altro è S. Nicola a salvare i bambini tenuti prigionieri, in attesa di essere uccisi e serviti a pranzo per gli avventori. Relativamente al cunto di Caronte, in passato esso circolava anche tra gli anziani di Roseto Valfortore (FG).
I Sanniti dedicavano lo stesso luogo a più divinità e sacrificavano loro degli animali, tra cui il maiale, e i prodotti della terra. Veneravano molte divinità cercando risposte ai fenomeni naturali che sfuggivano al loro controllo. Le più importanti erano: Iuveis (Giove), signore supremo; Mamerte (Marte), dio della guerra; Kerres (Cerere), dea generatrice delle messi; Fluusai (Flora), protettrice dei germogli. Poi vi erano le divinità secondarie: Famel, la dea terra; Heres, che accompagnava il popolo in guerra con Mamerte; Fatui e Ferocia, che proteggevano i pastori; Lucina, dea della natalità, fondamentale data l’elevata mortalità.
Nonostante l’orgoglio dei Sanniti nel voler conservare la propria identità, dopo la colonizzazione vi era un libero scambio di divinità coi Romani.
Il contatto con la cultura greca, avvenuto probabilmente attraverso i Dauni e i discendenti dei coloni greci della Magna Grecia, indusse i Sanniti a credere nell’aldilà. Lo dimostrano alcune pitture tombali. Tenevano molto agli auspici ed alla previsione del futuro e, più di altri popoli italici, avevano un assoluto rispetto per i riti religiosi, da cui facevano dipendere la propria esistenza terrena e il viatico ultraterreno.
I Sanniti, nella religione, cercavano risposte alle loro problematiche esistenziali, come il perché della morte, della giustizia e della verità. Ma questo vale anche per gli altri popoli. Ci si rifugia nella giustizia divina, perché quella umana è fallace e spesso ingiusta.
Se la storia e la letteratura insegnano che le divinità pagane avevano alimentato guerre tra i popoli parteggiando per l’uno o per l’altro, anche le religioni monoteistiche, anziché alimentare la concordia, generano spesso discordie e conflitti tra i popoli o le etnie.
Ritornando ai contadini, anch’essi hanno sempre cercato risposte nella religione. Facevano voti e chiedevano grazie rivolgendosi a Dio, a Cristo, alla Madonna e ai santi. Per una grazia ricevuta erano offerti dai fedeli non solo comportamenti di penitenza e la pratica dei sacramenti, ma anche somme di denaro, oggetti personali d’oro, ex voto in argento, raffiguranti la parte del corpo guarita per intervento soprannaturale, foto del miracolato e quadri dipinti con la scena dello scampato pericolo, che erano esposti per anni sui muri delle chiese e dei santuari. In qualche caso vi erano dei lasciti a favore della Chiesa, soprattutto da parte di chi non aveva eredi, perciò le parrocchie potevano ritrovarsi a gestire cospicui patrimoni immobiliari, costituiti da case e terreni.
Quando una richiesta di intervento soprannaturale non era esaudita, ci si rivolgeva alle pratiche magiche. Durante le due guerre mondiali, le famiglie erano in trepidazione per la sorte dei figli soldati, arruolati e avviati al fronte. Quando passavano dei mesi senza ricevere più notizie, le mamme si allarmavano e si recavano da qualche fattucchiera, che godeva fama di veggente, per conoscere la sorte dei propri figli. Capitava che, dopo avere ascoltato le rassicurazioni della veggente, una volta tornate a casa esse non trascurassero di pregare. Insomma si cercava di attivare una sinergia di forze e poteri diversi, anche inconciliabili tra loro, pur di pervenire a una soluzione positiva di ciò che assillava le famiglie.
|
Il convento di Montecalvo Irpino, non più esistente, in un dipinto di Angelo Siciliano del 2005. |
In passato vi era un’alta natalità, ma anche un’elevata mortalità infantile, a causa della selezione naturale e delle precarie condizioni di vita. Quando un bimbo o una bimba stava male, e la sua vita appariva appesa a un filo, tante mamme montecalvesi facevano un voto a S. Antonio da Padova, dedicandogli l’infermo. A guarigione ottenuta, il bimbo o la bimba era vestito per un anno come un frate francescano, col saio marrone con cappuccio, il cordone e i sandali. Sino agli anni Sessanta del Novecento, qualche ragazza in età post puberale e, nei decenni precedenti, addirittura qualche giovane maschio ormai quasi uomo, per grazia ricevuta, si vestivano anch’essi come S. Antonio per un anno. |
In tutti questi casi, però, il saio non arrivava sui piedi, ma si arrestava sotto il ginocchio. Anche a me, quando avevo poco più di un anno d’età, e nonostante mio padre fosse comunista, dopo essere scampato a delle febbri viscerali tremende, che ogni estate falcidiavano tante giovani vite, capitò d’essere vestito da munaciéddru come S. Antonio. Alcuni maschi, votati a S. Antonio, che avevano indossato il saio per un anno, si erano visti affibbiare l’epiteto zi’ mònicu, che accompagnava il soprannome. E così a Montecalvo ancora qualcuno si ricorda di zi’ mònicu di Cècciu, zi’ mònicu Lu Casali e zi’ mònicu Scampacàrdi. Lu mònicu Gintìli, invece, era un frate che dismise il saio per prendere moglie e avere figli.
Da ragazzino, la mattina di un 13 giugno, festa di S. Antonio, mi capitò d’assistere, durante la messa solenne nell’allora seicentesco convento barocco di Montecalvo, all’ingresso in chiesa di una lunga fila di postulanti, contadini montecalvesi e dei paesi vicini, strisciare sulle ginocchia nude dall’ingresso della chiesa sino all’altare, in un’atmosfera di suggestione, compassione e curiosità da parte della folla di fedeli presenti alla cerimonia religiosa. Alla fine della messa furono letti i nomi degli emigranti e loro discendenti, che dall’estero non avevano mancato di inviare il proprio obolo.
Molte mamme erano solite cucire sul grembiulino (lu cacciamàni) dei propri bimbi alcune medagliette di santi. In questo caso si trattava di devozione, ma anche di superstizione, perché in base alle credenze popolari esse avevano una funzione apotropaica, allo scopo di proteggere il piccolo contro il malocchio degli invidiosi e il maligno.
Un altro caso, di devozione e superstizione insieme, riguardava qualche contadino che, durante i violenti temporali estivi con folgori e grandine, invocasse S. Barbara, protettrice contro le folgori e patrona degli artiglieri, minatori e vigili del fuoco, e poi compisse il rito propiziatorio di stracciare delle figurine di santi e, uscito all’aperto, di scagliare i frammenti verso il cielo.
I sacramenti come il battesimo e la cresima, oltre ad assolvere il personale rapporto del fedele con Dio, servivano ai nostri avi per instaurare dei rapporti affettivi o di amicizia con delle famiglie estranee. Infatti, i padrini e le madrine erano scelti con oculatezza, dalla famiglia del battezzando o del cresimando, allo scopo di allargare la cerchia del parentado o per meritarsi l’amicizia delle famiglie borghesi più in vista del paese. Dopo il battesimo o la cresima ci si chiamava compari o comari per tutta la vita. Dire ‘simu San Giuvànnu’, con chiaro riferimento a S. Giovanni Battista, significava che tra due famiglie vi era stato il battesimo di un neonato.
Anche il rito del “finto battesimo”, che si celebrava in alcune regioni meridionali, come la Calabria e la Sicilia, tra due ragazzine in mezzo a una schiera di coetanei, dove il battezzato era una bambola e il celebrante un adulto travestito da prete, assurgeva a valore simbolico di un battesimo autentico. La “mamma” della bambola e la “madrina” si sarebbero chiamate comari, cummà, per il resto della loro vita. Anche a Montecalvo, come riferisce il giornalista Mario Aucelli, ricercatore di fatti e cose locali, nella piccola borghesia esisteva il battesimo della bambola o del bambolotto, che si organizzava in famiglia invitando i bambini del vicinato che potevano così degustare i dolci preparati per l’occasione dalla padrona di casa. In effetti, in questo caso, la messinscena serviva principalmente per la socializzazione dei bambini. Le famiglie contadine, invece, non potevano permettersi i dolci e il loro finto battesimo si riduceva a una filastrocca “San Giuvànnu ‘ntélle ‘ntélle”. Talvolta due ragazzine, ingaggiate come braccianti all’età di 8-10 anni, o pastorelle che accompagnavano degli ovini al pascolo, si posizionavano frontalmente, agganciavano i loro mignoli destri e recitavano insieme: Cummàre ‘ntélle ‘ntélle / ci sciuppàmu nu capélle. / Nu capélle e na castagna / ci facìmu San Giuvànnu. / San Giuvànnu a l’anni chi véne / ci vulìmu sèmp béne! (Comare, per giocare / ci strappiamo un capello. / Un capello e una castagna / ci facciamo S. Giovanni. / S. Giovanni, l’anno che viene / ci vogliamo sempre bene! – Le informatrici sono Annunziata De Furia e mia madre, Mariantonia Del Vecchio). Era un modo per cementare un rapporto di amicizia, fatto anche di complicità e solidarietà, in un mondo in cui si era subito adulti, senza giochi e senza giocattoli, e per tutta la vita le due ragazzine sarebbero state amiche e comari, come se tra loro fosse intercorso un vero battesimo.
È molto significativo che i termini “cristiano” e “cristiana”, nel Meridione, ancora oggi sono sinonimi di uomo e donna.
|
Il campanile della chiesa, non più esistente, del Santissimo Corpo di Cristo prima del 1930, in una rielaborazione di Angelo Siciliano. |
Relativamente a S. Pompilio, nato da nobile famiglia montecalvese, divenuto padre scolopio, teologo, educatore dei giovani, mistico devoto del Sacro Cuore, dell’Eucaristia e della Madonna, non sono stati creati canti, ma nella cultura popolare ricorrevano tre aneddoti: il suo dialogo con Mamma bella; le sue preghiere recitate con i teschi dei defunti esposti nella chiesa del Purgatorio (Lu Prijatòriju), dove dei ragazzacci a volte gli tiravano dei sassi; la salma di sua madre, che si era ben conservata con il foulard in testa (lu maccatùru) e la veste blu a pallini, à pois (a ucchjiciéddri), nella tomba di famiglia nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo (Lu Santìssimu). Entrambe queste chiese, molto care al santo, furono abbattute dopo il disastroso sisma del 1930. In passato, il basso tenore di vita, il modo di vivere semplice e le difficoltà di comunicazione ponevano seri limiti allo spostamento delle persone. Tuttavia, i fedeli si avventuravano in pellegrinaggi, faticosi e irti di pericoli, anche al di fuori delle ricorrenze giubilari, per raggiungere lontani santuari. Sino alla metà del Novecento, pure da Montecalvo partivano i pellegrini. Portavano con sé vettovaglie costituite da pane, vino, dolci caserecci e companatico come frittate, formaggio (casu) e salumi stagionati (sausìcchji e suprissàte). Percorrevano a piedi anche centinaia di chilometri, per raggiungere la meta. |
Erano viaggi di fede, che consentivano di fare la conoscenza con altre realtà e socializzare coi compaesani e con la gente di altri paesi. Nei luoghi sacri si pregava, si facevano voti e si ottenevano indulgenze. Si pernottava nelle locande e nelle taverne dislocate lungo i tragitti. Canti e preghiere accompagnavano il loro cammino.
I fedeli partecipavano ai riti religiosi e alle celebrazioni festive del proprio paese e dei paesi vicini. Ma il sacro era vissuto, anche al di fuori della liturgia, attraverso i canti religiosi, le ninne nanne, le filastrocche, le preghiere, i detti. Il tutto come tradizione orale che le generazioni dei secoli passati, epoche che dovevano apparire immutabili, hanno elaborato e tramandato.
Anche l’insieme delle operazioni che costituivano la “gestione del lutto”, dalla veglia del caro estinto al pianto funebre, al consòlo e alla settimana di “fuoco spento”, può essere fatto rientrare nella sfera del sacro, inteso come segno identificativo di una civiltà.
I montecalvesi sono stati sempre molto devoti alla Madonna di Montevergine, o Mamma Schiavona, cioè Mamma scura di pelle, invocata come Madonna di la Shcavunìja. Ed è un appellativo, questo, includente i più begli attributi affettivi, con cui essi le si rivolgevano, sia nei canti che nelle richieste di grazia o di esaudimenti di desideri. Schiavònia, invece, in passato indicava la Dalmazia e più precisamente l’attuale Bosnia.
|
Pellegrine montecalvesi a Montevergine. Foto tratta da Montevergine, tradizioni e canti popolari religiosi, di Raffaele Mario Baratta, edizioni del Santuario di Montevergine, 1974. |
A Montecalvo ho raccolto quattro canti dedicati alla Madonna di Montevergine. Due sono le versioni con qualche variante dello stesso canto di pellegrinaggio, cantato dai pellegrini provenienti dai diversi paesi della Campania e delle regioni limitrofe. Lo si cantava lungo il tragitto di andata e ritorno e descrive i punti nodali del percorso, il dialogo affettuoso con la Madonna e le grazie ricevute. Gli altri due sono canti devozionali e narrano di due miracoli. Nel primo, “Il miracolo della lettera”, la Madonna fa scendere dal cielo una lettera davanti al giudice, che sta per condannare un innocente. Costui non ha mai ‘ncammaràtu, cioè non ha contravvenuto alla regola dell’astinenza da determinati cibi, ed ora che è ingiustamente accusato di omicidio, è assolto grazie all’intervento provvidenziale della Madonna. Nel secondo, “La Madonna di la Shcavunìja”, la Madonna salva da morte certa una donna spinta in un burrone dal marito, alle cui orecchie è giunta la calunnia che lei lo tradisce con il compare. |
Costui è ridotto in cenere durante la celebrazione della messa nel santuario di Montevergine. Sino all’Ottocento si camminava a piedi e la distanza da coprire, andata e ritorno, era di oltre cento chilometri. Nella scalata al monte Partenio, giunti in prossimità del santuario, nella località denominata Scauzatùru, i pellegrini si toglievano le scarpe e proseguivano a piedi nudi e, dal posto chiamato il Casóne, non potevano mangiare cibi costituiti da carne o conditi con grasso di animale.
Dal paese si organizzavano gruppi di pellegrini che, per effettuare la trasferta, impiegavano tre o quattro giorni, pernottando nelle locande dislocate lungo il tragitto. Qualcuno ancora ricorda una tragedia toccata a un gruppo di pellegrini montecalvesi. Essi, qualche anno prima che scoppiasse il secondo conflitto mondiale, nel recarsi a piedi a Montevergine, nei pressi del ponte sul fiume Calore, furono investiti da un camion con i freni rotti. L’incidente provocò morti e feriti.
I benestanti si recavano al santuario co lu sciarabàllu, il calesse. Qualche altro s’avventurava co lu trajìnu, il carretto da lavoro.
Nella prima metà del Novecento i veicoli a motore cominciarono a risolvere il problema della distanza e della scalata al monte Partenio e, col pullman, masse di pellegrini si riversavano prima a Montevergine e poi a Mugnano del Cardinale, per fare visita a Santa Filomena, martire in epoca romana depennata dal calendario ecclesiastico nel 1965, dopo il Concilio Vaticano II, sul conto della quale ho raccolto il canto devozionale Santa Filumèna, che ne sintetizza la storia personale. Poi si proseguiva per Pompei, dove si visitava il santuario della Madonna del Rosario e si pernottava nella “Casa del pellegrino” stando seduti o, per i più fortunati, che giustamente erano i bambini, stesi su dei tavoli col piano di marmo, per passarvi una notte che pareva interminabile.
Durante il tragitto si cantava, si pregava e, nei luoghi di sosta, si pranzava al sacco, si beveva e alcuni ballavano la tarantella accompagnandosi con tamburelli, organetto e nacchere. I bambini erano gratificati col sorbetto.
Il secondo giorno si proseguiva per Napoli, dove si visitava il duomo di S. Gennaro. Sul conto del santo circolava un aneddoto curioso, secondo cui un fedele, deluso per una richiesta di grazia non esaudita, con gesto sacrilego, aveva rotto e asportato il naso alla sua statua e l’aveva gettato in mare. Miracolosamente il naso era stato in seguito ripescato in una rete di alcuni pescatori, che l’avevano portato in duomo per essere rimesso al suo posto, sul volto della statua.
Visitato il porto, ammirati il mare e le navi, e per tanti era la prima volta, dopo aver pasteggiato si faceva ritorno al paese. Nel pullman, naturalmente si cantava. Per giorni, l’avventura appena conclusa era rivissuta nei racconti dei partecipanti, come se fosse una favola.
A Montevergine era stata acquistata la ‘nfèrta, serto di castagne infornate, e altri souvenir, quali ciondoli, medagliette, collanine e immaginette della Madonna da distribuire a fidanzate, amici e parenti rimasti ad attendere in paese.
Molta impressione destava nei pellegrini la visita alla mummia del Beato Giulio, esposta in santuario. Tuttavia, pure a lui erano rivolte richieste, di intercedere verso Dio per ottenere grazie e favori.
|
Ragazze montecalvesi a Montevergine, che fanno il nodo con le ginestre. Foto tratta da Montevergine, tradizioni e canti popolari religiosi, di Raffaele Mario Baratta, edizioni del Santuario di Montevergine, 1974. |
Anche le ragazze montecalvesi, che erano fidanzate, come erano solite fare pure quelle di altri paesi, si portavano nella macchia non molto distante dal santuario, e facevano un nodo con i rami sottili delle piante di ginestra, come voto di matrimonio. Tradizione esigeva che il nodo fosse fatto solo con la mano sinistra. La speranza era di farvi ritorno l’anno successivo, a matrimonio avvenuto, per poterlo sciogliere. Ma tanti nodi rimanevano legati per sempre. Il verbo ‘ncammarà significa commettere peccato mortale consumando carne, insaccati, uova, latticini, dolci con uova, o altri alimenti conditi con lardo o sugna di maiale, di venerdì, giorno della passione di Cristo, e nel periodo di quaresima. Tutti i venerdì erano da rispettare, ma quelli di marzo in modo particolare: infatti, il peccato di non astinenza dagli alimenti suddetti era più grave se commesso in uno di tali giorni.Il menù del venerdì, anche presso i contadini, doveva prevedere un primo piatto condito con olio e per secondo baccalà o pesce cucinato con olio. Pure il giorno della vigilia di Natale era da rispettare e, infatti, il detto “Fa bigìlija” significa che una persona segue la regola del digiuno. |
I contadini rispettavano la “tradizione del magro”, imposta ai monaci di Montevergine da S. Guglielmo da Vercelli, fondatore del santuario agli inizi del XII secolo, e divenuta obbligatoria pure per il popolo. Anche se nel 1954 questa tradizione fu abolita, con intervento della Santa Sede, essa era ancora rispettata da molti contadini sino agli anni Settanta (Cfr. Montevergine, tradizioni e canti popolari religiosi, di Raffaele Mario Baratta, edizioni del Santuario di Montevergine, 1974).
In onore di S. Gerardo Maiella, al cui santuario di Materdomini si recavano i pellegrini montecalvesi, ho registrato un canto di pellegrinaggio che ha la stessa melodia di quello relativo alla Madonna di Montevergine.
A Montecalvo ho raccolto anche il cunto “La Carrara di Santu Jagu”, che narra dell’apostolo S. Giacomo, che una notte ruba, nei campi coltivati dal vicinato, del fieno per i suoi conigli. Dallo strascico di fieno, che perde lungo il tragitto, trae origine la nostra galassia, la Via Lattea. Il suo santuario è a Santiago di Compostela, nella provincia di La Coruña in un altopiano dell’estrema Galizia, nella Spagna nord-occidentale. Questo cunto arrivò da noi, probabilmente, con la dominazione degli spagnoli nell’Italia meridionale. Non si hanno notizie a riguardo di pellegrini nostrani che, nel Medioevo, si recassero a piedi in Spagna percorrendo la Via Francigena, come facevano quelli dell’Italia centro-settentrionale.
In passato a Montecalvo esistevano due ospedali, intesi come luoghi di ospitalità: quello del XIII secolo di Santa Caterina d’Alessandria vergine e martire, con annessa chiesa fondata nel 1099 dai crociati locali al ritorno dalla Terra santa, sopra via Lungara Fossi (alla santa è dedicata nella terza decade di novembre un’importante fiera istituita nel Medioevo); quello della Santissima Annunziata del XVI secolo, nel rione Annunziata. Con le numerose locande e taverne locali, entrambi davano ospitalità a pellegrini, mercanti e viandanti, che percorrevano la via Appia-Traiana, che partiva da Roma, passava per Benevento, attraversava il nostro territorio e arrivava sino a Brindisi, dove ci si poteva imbarcare per Gerusalemme.
I canti montecalvesi della Passione di Cristo sono tre, di cui “Giuvidì Santu” ha tre versioni. Si potrebbe parlare di teatro “incarnato”, perché sicuramente questi canti erano stati mutuati da cerimonie sacre, che si tenevano nelle chiese o nelle piazze dei paesi, nei periodi pasquali dei secoli passati, e arricchiti con scene e parole dialettali dai nostri contadini.
I canti religiosi si sono trasmessi per via orale, come gli altri canti popolari. Di uno stesso canto, si hanno talvolta più versioni, con lievi o sostanziali differenze, secondo la contrada, l’etnia che l’ha creato o adottato e tramandato.
Trattasi di un patrimonio orale quasi scomparso, considerato “cultura marginale”. Esso rappresenta o fa parte a pieno titolo della “controstoria”, vale a dire la storia non scritta trasmessa dal popolo.
I canti religiosi montecalvesi, tranne due, quelli relativi ai pellegrinaggi ai santuari di Montevergine e di Materdomini, sono per lo più canti narrativi devozionali. Essi trasmettevano non solo aspetti della liturgia, ma svolgevano soprattutto una funzione educativa nei confronti dei giovani, principalmente verso le ragazze. Erano cantati dalle donne sia durante i duri lavori nei campi, quali la semina, la rastrellatura, la sarchiatura, la mondatura delle messi, la mietitura e la raccolta delle olive, sia nei freddi pomeriggi invernali, accanto al focolare, la cimminìja, dove esse sferruzzavano e intrattenevano la numerosa prole.
Nel 1949 a Montecalvo vi fu una terribile carestia, a causa della siccità. Gli anziani hanno ricordato sempre quell’anno, come l’annu di la malannàta. Si raccontava che in quell’estate non si era raccolto grano, ma neanche paglia a sufficienza da fare strame per le bestie. Insomma un anno nero per tutti, che sommava miseria alle già precarie condizioni di sussistenza, lasciate in eredità dal conflitto mondiale da poco conclusosi. Fu creato un canto di invocazione a S. Antonio da Padova, cantato dai contadini nelle processioni propiziatorie che erano organizzate, e in seguito anche durante i lavori nei campi. E sempre a S. Antonio sono dedicati altri due canti, di cui uno per i suoi tre miracoli.
S. Liberatore è un santo di Ariano Irpino e, nella contrada omonima, esiste ancora la chiesa dove si celebra annualmente la sua festa. Sino all’inizio del Novecento, i contadini montecalvesi gli erano molto devoti ed erano soliti recarvisi in pellegrinaggio. Cogli anni questa tradizione si è perduta. Personalmente ho potuto registrare e trascrivere il “Canto a S. Liberatore” di 14 strofe. In questo canto, una ragazza è incoraggiata dalla madre a recarsi da sola a S. Liberatore, dato che è d’accordo con un giovane, il quale tenterà di approfittarsi della figlia lungo il tragitto. La cosa si mette male per la giovane, ma il delitto non si consuma, grazie all’intervento provvidenziale e miracoloso di un vecchietto, San Liberatore, che la salva da morte certa. Nell’ultima strofa, è racchiusa la morale molto cruda della narrazione: Nunn’èsce nisciùna figlia puttana, / si ‘nn’éja primu la mamma ruffijàna!
Sempre nel territorio di Ariano, in contrada Starsa, che in epoca sannitica e poi romana si chiamava Equo Tuticum, una zona lontana e opposta territorialmente a quella in cui si trova la chiesa di San Liberatore, esiste un luogo denominato S. Eleuterio, il cui nome Eleutheros, dal greco, significa libero, indipendente.
Ho avuto modo di raccogliere anche quattro canti sacri satirici: “Li diasìlli pi la bunàlima di la jummènta”, “Li diasìlli”, “San Fidéle” e “San Cilàrdu” (Il dies irae per la buonanima della giumenta, Il dies irae, San Fedele e S. Gerardo). Nei primi due sono prese in giro differenti classi sociali, intonando in modo parodistico il Dies irae. Nel terzo, sono presi in giro i devoti di S. Fedele. Nel quarto, che è un canto di pellegrinaggio, S. Gerardo è un ragazzo che se la faceva nei calzoni.
I santi delle città e dei paesi vicini, ai quali i montecalvesi facevano visita, in occasione delle feste in loro onore, erano: S. Fedele di Castelfranco in Miscano; la Madonna della Neve di Buonalbergo; S. Michele di Casalbore; S. Bartolomeo (Santu Scurciògna) di Greci; S. Lorenzo (Santu Laviriénzu) per la sua fiera, S. Liberatore, la Madonna del Carmine e il santuario della Madonna di Valleluogo (Li Barluóghi) il giorno delle Pentecoste, ad Ariano Irpino; la Madonna delle Grazie di Benevento.
Va detto pure che le feste religiose, in un mondo caratterizzato da una diffusa miseria materiale, in cui circolava il detto “Nun téne mancu l’uócchji pi chjagne” (Non ha neanche gli occhi per piangere), una volta tanto fornivano ai contadini l’occasione di mangiar bene. La carne e il pane bianco di grano erano i generi alimentari che nobili e borghesi si potevano permettere a tavola più o meno ogni giorno.
Tutte le feste religiose in paese erano importanti, ma non erano uguali tra loro, perché era come se la gente facesse una sorta di graduatoria d’importanza tra i santi. Nel tempo si è assistito alla decadenza di qualche festa, come quella in onore di S. Felice martire.
Il giorno della festa si addobbava l’altare, si preparava la statua e si celebrava la messa solenne. Dei volontari si offrivano come portatori in spalla della statua per le vie del paese. I portatori di S. Antonio da Padova, decenni addietro partecipavano a una sorta di asta a pagamento per accaparrarsi un posto da portatore. Altri volontari precedevano la processione e andavano per la questua con una busta di pezza rigida in mano per la raccolta delle offerte, in genere monetine e banconote di piccolo taglio. Le statue oscillavano sulle processioni. Le ragazze, affacciate ai balconi sulla cui balaustra erano esposte le belle coperte decorate di famiglia, facevano piovere sulla statua che passava di sotto petali di rose, fiori di petti d’angelo e di ginestra. Ogni 100-200 metri era posizionato nella via un tavolo, con tovaglia o coperta decorata, su cui i portatori appoggiavano la statua e tiravano il fiato. Si avvicinavano i fedeli e attaccavano delle banconote di grosso taglio ai nastri appesi alle spalle della statua. All’abito della Madonna della Libera, le fedeli fissavano dei gioielli d’oro. Poi si facevano il segno della croce e mormoravano delle invocazioni o dei ringraziamenti per richieste già esaudite. La processione continuava e in certi punti del paese si sparavano i botti in segno di giubilo. Si pregava, si cantava e si recitava il rosario lungo il tragitto, alternandosi con la banda musicale. Al rientro della processione la statua era spogliata delle offerte. La sera c’era la “musica” e lo struscio tra le bancarelle di dolciumi e pazziarèddre, giocattoli come palloncini, pupe di stoffa e pallette con l’elastico piene di segatura. Alla fine della festa, verso la mezzanotte, vi erano i fuochi pirotecnici e tutti col naso all’insù. Inevitabili erano i commenti e i confronti campanilistici, con le feste patronali dei paesi vicini. I fuochi più belli inevitabilmente erano quelli dei paesi più ricchi.
Le feste fornivano ai contadini anche l’occasione di grandi ubriacature nelle diverse cantine del paese, per dimenticare la precarietà della propria esistenza e le fatiche quotidiane cui erano costretti da una vita grama. Molti di loro, rientrando a casa dopo la festa, non si trattenevano dall’essere violenti con le mogli e dare sfogo alle proprie frustrazioni nei fumi dell’alcol.
Molti contadini erano incalliti bestemmiatori. Ma certi artigiani non erano da meno. Le donne bestemmiavano raramente. Esistevano due tipi di bestemmie, distinte in peccati mortali e peccati veniali. Le prime riguardavano Dio, Cristo, la Madonna e i santi. Le seconde, oggi cadute in disuso, riguardavano i morti delle persone, cui erano indirizzate le bestemmie. Nel dialetto romanesco, però, ancora oggi permane questo tipo di bestemmia, come quando si sente qualcuno esclamare: “A li mortacci sua!”. Di qualcuno si diceva che bestemmiava come “terra crepata”, adombrando con questo paragone la dannazione e la distruzione della nostra amata terra. Nella mia ricerca ho raccolto diverse forme di bestemmia, alcune assai singolari o paradossali. Ma a tutti quei bestemmiatori, a vedere gli orrendi crimini che quotidianamente sono commessi nel nostro mondo globalizzato, si potrebbe dare l’assoluzione postuma, considerandoli esseri umanamente deboli, perché inclini alla bestemmia, ma che sapevano essere anche devoti.
Nel mondo contadino vi erano pure uomini pii che, durante il periodo della quaresima, organizzavano con le proprie famiglie la recita e il canto del rosario nelle case rurali, in cui abitavano. Il rosario cantato faceva parte di una tradizione ottocentesca, molto probabilmente ereditata dai secoli precedenti, assai sentita e seguita sino agli anni Quaranta del Novecento. Era una consuetudine religiosa, dei contadini montecalvesi che si riunivano, anche più famiglie, per assolvere a questo atto di devozione e che, grazie a mia madre, ho registrato e trascritto nel 1999. La parte cantata del rosario, costituita dal “Salve Regina” e dai simboli della Passione, “Fiérru fracèllu (Il flagello)”, “Chjuóvi crudeli (Chiodi crudeli)” e “Spina pungente”, faceva seguito a tutte le preghiere recitate, fatta eccezione del “Padre nostro”. Il rosario recitato e cantato, infatti, si chiudeva con questa preghiera, recitata tante volte quanti erano i santi importanti onorati in paese: S. Felice, S. Antonio e S. Giuseppe. Un “Padre nostro” era recitato alla fine per tutti gli altri santi.
Cambiamenti politici e sociali nel secondo dopoguerra e loro riflessi sulla pratica
religiosa
Con la caduta del fascismo, avvenuta l’8 settembre 1943, oltre a cambiare il panorama politico e sociale nazionale, muta anche quello locale.
Nel gennaio 1944, il confinato calabrese Antonio Smorto (1909-2007) fonda, con alcuni militanti locali, in via Roma a Montecalvo, la sezione del Partito comunista italiano col nome di “Circolo di cultura della Sezione Comunista Giuseppe Cristino”, con la benedizione del parroco don Michele Bellaroba, sia alla sezione che alla bandiera rossa, ricamata da Vincenzina La Vigna, fidanzata di Smorto e presidente della locale Azione Cattolica Femminile. Sempre Smorto istituisce la locale Camera del Lavoro, per la tutela dei diritti dei braccianti, di solito ingaggiati dai massari, e degli altri lavoratori.
Il 15 maggio 1944, è fondata la sezione del partito della Democrazia cristiana a Montecalvo e il primo segretario è Davide Panzone.
Con la lista frontista della Spiga, composta dai social-comunisti, il 7 aprile 1946, è eletto a primo sindaco democratico del secondo dopoguerra il socialista Pietro Cristino, un perseguitato del fascismo. È padre di Giuseppe, cui è intestata la locale sezione del PCI, morto nel 1941 in Spagna, prigioniero del dittatore Francisco Franco, dopo aver combattuto nella guerra civile del 1936-1939, come arruolato nelle Brigate Internazionali. Vicesindaco è nominato il socialista Ciccio Panzone, che in seguito sarà eletto sindaco a sua volta.
L’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 sancisce la vittoria della repubblica sulla monarchia e se la Chiesa cattolica ha goduto di privilegi e protezioni durante il regime dittatoriale, ora con la repubblica il quadro muta completamente. Anche se ad essa, in forza del riconoscimento, da parte della Costituzione repubblicana, degli accordi conseguenti ai Patti lateranensi del 1929 tra Stato e Chiesa, è concesso di esercitare il proprio potere spirituale sul territorio italiano con un’autonoma organizzazione, viene sancito il principio della libertà religiosa e dell’uguaglianza di tutte le confessioni di fronte allo stato italiano.
Anche la realtà montecalvese, con circa cinquemila residenti, a partire dal secondo dopoguerra, in fatto di religione va incontro a mutamenti, perché non vi è più solo la religione cattolica. Infatti, i protestanti di Montecalvo, li putristànti, a seguito di un fervente proselitismo, nel 1947 si costituiscono in Chiesa Evangelica dei Pentecostali, con sede a Corsano, potendo contare su oltre cento convertiti alla nuova fede. Qualche decennio dopo comincia in paese il proselitismo dei testimoni di Geova. Sia i Pentecostali che i testimoni di Geova espellono dalla loro liturgia la Madonna e tutti i santi, astenendosi dal partecipare ai riti cattolici e ai pellegrinaggi.
In quegli anni, sino al 29 novembre 1960, quando dopo 14 anni di lotte, per solo 4 voti di scarto è eletto sindaco il democristiano Marcello De Cillis, Montecalvo è una delle roccaforti rosse dell’Irpinia e i rapporti tra la sinistra e la Democrazia cristiana, che è vicina alla Chiesa cattolica, sono di lotta politica anche aspra. I canti politici montecalvesi di quel periodo, da me raccolti, documentano fatti, allusioni ingiuriose e pettegolezzi tra le due parti avverse. Ma non vi sono scontri tra rossi e cattolici. Più che un ateismo di matrice ideologica, tra i comunisti locali serpeggia un sentimento di anticlericalismo verso i parroci e i frati del locale convento che promuovono, in prossimità delle scadenze elettorali, adesioni a favore del voto alla DC. Poi persiste una questione spinosa, non immune da pregiudizi: qualche parrocchia è intestataria di diverse terre, per le quali i contadini pagano l’affitto e tra essi tanti sono rossi. Il comunismo propugna il motto “La terra ai lavoratori!”. Tuttavia, tante famiglie rosse partecipano ai pellegrinaggi e alle feste religiose del paese. Né più né meno dei democristiani.
Col XXI secolo si arriva finalmente a noi. Si può dire che i contadini sono scomparsi. Molte campagne sono abbandonate, perché il reddito, che da esse si potrebbe ricavare, non consente una vita dignitosa. Tutto ciò che una volta era prodotto in queste terre, ora lo si compera nei negozi o nei supermercati. Qualche vecchio sopravvive per rammentarci com’era il mondo di una volta. Chi coltiva la terra, oggi si chiama produttore o imprenditore agricolo. La cultura secolare dei contadini, compresa quella religiosa, ha fatto il suo tempo e ora ha valore in quanto memoria. A patto che la si riesca a raccogliere e documentare per i posteri. In essa sono rintracciabili le nostre radici, come pure le spiegazioni per certi comportamenti attuali, che a volte appaiono incomprensibili.
Ora si offrono nuove opportunità ai fedeli. I tour operator organizzano i pellegrinaggi in aereo a Fatima, a Santiago di Compostela, a Lourdes e a Gerusalemme. Addio, via Francigena! I nuovi romei arrivano e ripartono da Roma per altre vie e con altri mezzi, rispetto al passato.
Decine di migliaia di giovani cattolici confluiscono ogni volta, da tutto il mondo, nella città in cui è fissato il raduno per la “Giornata mondiale della gioventù”.
Questa è la nuova realtà dei pellegrinaggi, della religiosità e della fede. Ma è una storia tutta da scrivere.
L’oro della memoria
Le medaglie, le monete e gli altri reperti, gettati nelle discariche urbane esistenti sin dal Medioevo sotto gli orti fuori le mura del paese, lungo Via Lungara Fossi in cima alla Costa della Mènola, sono scampati all’incuria, alla distruzione con i colpi di zappa, con cui si coltivava la terra, alla dispersione e all’erosione degli agenti atmosferici nel terreno coltivo.
In futuro saranno esposti nel Museo della Religiosità Montecalvese e della Memoria Pompiliana di Montecalvo Irpino, creato con grande abnegazione dall’abate don Teodoro Rapuano, 26 medaglie sacre, un piccolo crocifisso e 8 monete del Settecento, tutti rinvenuti in oltre 50 anni di ricerca tra le zolle di contrada Costa della Mènola a Montecalvo. Di essi, il crocifisso e alcune delle 26 medaglie sono pubblicati a pag. 8 del mio calendario artistico-culturale del 2007, realizzato grazie alla sponsorizzazione del Comune di Montecalvo Irpino, mentre le 8 monete del Settecento sono inedite.
Le medaglie sacre rappresentano la religiosità, la fede e la devozione di almeno quattro secoli di vita dei progenitori montecalvesi. Assieme alle monete del Settecento e ai “reperti” del sacro popolare ci restituiscono, attraverso l’humus della cultura orale e della storia non scritta degli antenati, gente umile, marginale e sconosciuta, l’oro della memoria del nostro passato. Un bene più prezioso dell’oro stesso.
LE MEDAGLIE RINVENUTE ALLA COSTA DELLA MÈNOLA
Le 26 medaglie sacre di rame, di bronzo, di ottone e una forse di stagno, e il piccolo crocifisso, rinvenuti in oltre 50 anni tra le zolle dei campi coltivati alla Costa della Menola di Montecalvo Irpino, testimoniano la devozione religiosa dei montecalvesi negli ultimi secoli. Hanno varia provenienza. La data più antica, riportata su una di esse, la n. 16, è il 1625.
|
|
Così si presentano al dritto e al rovescio (dr. e rov.):
Med. n. 1: dr. – Immagine della Madonna più la scritta: B.V. MARIA IMMACOLATA 1854; rov. – Immagine di Gesù più la scritta: S. CUORE DI GESÙ.
Med. n. 2: dr. – Immagine di santo più la scritta: B. GERARDO MAIELLA DEL SS. REDENTORE-RICORDO DEL SANTUARIO; rov. – Altare più la scritta: CAPPELLA DEL B. GERARDO NEL SANTUARIO DI CAPOSELE.
Med. n. 3: dr. – Quadro di Madonna con Bambino più la scritta: S. MAR. ARCI ORA PRO NOBIS; rov. – Cerbiatto sotto due rami di alloro ad arco più la scritta: URRA REFIGIRDI S. M. DELL’ARCO CORONAT NEL DÌ 8 SETTEMBRE 1874.
Med. n. 4: dr. – Immagine di S. Francesco più la scritta: OASI S. FRAN.; rov. – Una croce mauriziana o trifogliata.
Med. n. 5: dr. – Immagine della Madonna delle sette spade, o sette dolori, più la scritta: ROMA; rov. – Immagine di santo più la scritta: S. CARO RO e tre lettere illeggibili.
Med. n. 6: dr. – Immagine di una santa più la scritta: S. ANNA AEMY; rov. – Immagine di Cristo più la scritta: SALVATOR MUNDI SALVA NOS.
Med. n. 7: dr. – Immagine di un santo più la scritta: ΩAN G. OR. P. N.; rov. – Immagine di santo che contempla una statua e una scritta di tre lettere: ANI.
Med. n. 8: dr. – Immagine di S. Domenico più la scritta: S. DOMIN AB PRD CUCUL; rov. – Immagine della Madonna delle sette spade, o sette dolori.
Med. n. 9: dr. – Immagine di santa più la scritta: S. GER.; rov. – Immagine di S. Pietro con lettere S. P. e altre tre lettere indecifrabili.
Med. n. 10: dr. – Vergine irraggiata più la scritta: B. VIRGIN CARSSONCI; rov. – Ostensorio più la scritta: parola illeggibile, SS. SACRAM.
Med. n. 11: dr. – Immagine di Madonna con Bambino più la scritta: S. MARIA LAURET; rov. – Immagine di crocifisso con croce trifogliata.
Med. n. 12: dr. – Immagine di un santo con le iniziali S. L. (S. Liberatore, S. Lorenzo o S. Luca?); rov. – Immagine dell’Arcangelo Michele.
Med. n. 13: dr. – Figura di santo con Bambino in piedi sul libro aperto sul palmo della mano sinistra (verosimilmente S. Antonio) e la scritta ROM; rov. – Santo che contempla il crocifisso.
Med. n. 14: dr. – Madonna di Loreto; rov. – Santo che contempla una statua con la sovrastante scritta ΩAN.
|
|
Med. n. 15: dr. – Santo con la scritta AHC; rov. – Santo che contempla una statua.
Med. n. 16: dr. – S. Elisa con la scritta: S. ELISA REG. PO.; rov. – Chiesa con due santi e la scritta: 1625.
Med. n. 17 a forma di cuore: dr. – Tre santi con le scritte: S. FRAN. SO, S. CAR. B., S. PHIL. BA; rov. – Due santi con le scritte: S. LUDO. BI, S. ROSA VI.
Med. n. 18: dr. – Madonna di Loreto; rov. – Cristo crocifisso e croce trifogliata.
Med. n. 19: dr. – Madonna con Bambino e santi con la scritta: M. SS. DEL ROSARIO POMPEI; rov. – Altare contornato da scritta: parola illeggibile, 1881 VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI.
Med. n. 20: dr. – Madonna del Rosario con Bambino e santi, di Pompei; rov. – Vuoto.
Med. n. 21: dr. – Madonna del Rosario con Bambino e santi, di Pompei; rov. – Elementi floreali.
Med. n. 22: dr. – Madonna con Bambino e due angeli con la scritta: MADONNA DI LORETO; rov. – Madonna con Bambino e la scritta: MADONNA DI MONTENERO.
Med. n. 23: dr. – Santa (verosimilmente S. Maria Goretti) con doppia scritta circolare in cui è decifrabile solo una parola, GORETTI; rov. – Croce che sormonta una M su due cuori, il tutto contornato da stelle.
Med. n. 24: dr. – Madonna con la scritta, in cui si leggono solo le lettere TO; rov. – Vuoto.
Crocif. n. 25: dr. – Figura orante con la scritta VITA PRES; rov. – Cristo crocifisso.
Med. n. 26: dr. – Madonna con la scritta: B. V. MARIA IMMACOLATA; rov. – Scritta: MEMORIA DEL MESE DI MARIA.
Med. n. 27: dr. – Busto di S. Pompilio Maria Pirrotti con la scritta: S. POMPILIO M. PIRROTTI; rov. – Santuario con la scritta: SANTUARIO CAMPI SALENTINO.
LE MONETE DEL 1700
RINVENUTE ALLA COSTA DELLA MÈNOLA
Le otto monete in rame furono coniate sotto i re Borboni: quattro sotto il regno di re Carlo II (1716-1788), diventato poi re Carlo III di Spagna nel 1759, dopo la morte senza eredi di suo fratello re Ferdinando VI, e quattro sotto il regno di suo figlio re Ferdinando I di Borbone (1751-1825), già IV come re di Napoli e III come re di Sicilia. Inquadrano il Settecento, il secolo in cui è vissuto il nostro santo, San Pompilio Maria Pirrotti (Montecalvo Irpino 1710 – Campi Salentina 1766).
|
|
Così si presentano al dritto e al rovescio (dr. e rov.):
Mon. n. 1: dr. – Effigie di re Carlo II con scritta: CAR D C UTE SIC REX; rov. – cartiglio a forma di scudo con scritta M 4 M 1756.
Mon. n. 2: dr. – Effigie di re Carlo II con scritta: CAROLUS II D G REX ; rov. – Stemma con scritta: SICILIA HIERUSA.
Mon. n. 3: dr. – Effigie di re Carlo II con scritta: CAROLUS II D G REX ; rov. – Stemma con scritta: SICILIA HIERUSA.
Mon. n. 4: dr. – Effigie di re Carlo II con scritta: CAROLUS II D G REX ; rov. – Stemma con scritta: SICILIA HIERUSA.
Mon. n. 5: dr. – Effigie di re Ferdinando IV con scritta: FERDINANDUS REX; rov. – Cavallo con aquila e scritta: parola parzialmente illeggibile -QUITAS, REGNI.
Mon. n. 6: dr. – Effigie di re Ferdinando IV con scritta: FERDINANDUS REX; rov. – Cavallo con aquila e scritta: parola parzialmente illeggibile -QUITAS, REGNI.
|
|
Mon. n. 7: dr. – Effigie di re Ferdinando IV con scritta: FERDIN IV SICIL REX P; rov. – Grappolo d’uva con scritta: C 4 1791.
Mon. n. 8: dr. – Stemma cinto di alloro ; rov. – Tornesi 5 con corona, con scritta 1798.
(Questo saggio, pubblicato parzialmente nel n. 9 del 2007 della rivista Disputationes Pompilianae e dal Corriere – Quotidiano dell’Irpinia del 30 giugno 2008, è nel sito www.angelosiciliano.com. Notizie su S. Pompilio e sul Museo della Religiosità Montecalvese e della Memoria Pompiliana possono essere riscontrate nel sito www.sanpompilio.it).
Montecalvo, 10 giugno 2008 Angelo Siciliano











